di Giuseppe Loda
Era una giornata non troppo calda. Seduto sulla mia poltrona preferita guardavo un documentario alla televisione, in cui mostravano delle meravigliose immagini di persone di ogni età, impegnate nella vendemmia in una minuscola valle, circondata da colline. Anche se non conoscevo il posto apprezzavo la sua bellezza. Quanto avrei desiderato esserci anch’io tra quelle persone, prendere tra le mani quei pesanti grappoli d’uva, tagliare il picciolo che li sosteneva alla vite e depositarli nel cesto.
Stanco, chiusi gli occhi e cominciai a ricordare di quando, da ragazzino, mi divertivo insieme ai miei amici a raccogliere l’uva nei campi.
Eravamo abituati a giocare sempre insieme, nella grande cascina dove vivevano i miei genitori, con altre famiglie di contadini. Quando sopraggiungevano i primi giorni d’autunno, i nostri genitori ci chiedevano di aiutarli nella vendemmia. Certo non era un granché di vigneto, i filari erano pochi, due o tre sul lato destro del nostro orto, al fianco di sedano, rape e verza. L’uva ricadeva in grappoli dalla vite: eravamo quasi obbligati a piegarci, per raccoglierla.
Per noi quello non era un lavoro, ma un divertimento, quell’uva tra le mani era un vero strumento di piacere.
Il giorno dopo la raccolta entravamo colmi di gioia in grandi recipienti, dove a piedi nudi schiacciavamo senza nessuna pietà quei grossi grappoli sugosi, che, con alacre regolarità, gli uomini versavano tutt’intorno a noi. Impossibile dimenticare il colore rosso, come di sangue denso, mischiato all’inebriante profumo di mandorle che emanava l’uva schiacciata. Non so se fosse l’importanza del compito che ci veniva assegnato, la grinta che spendevamo nel portarlo a termine, o il vapore d’uva che respiravamo… per tutto il tempo in cui le nostre esili gambette si muovevano ritmicamente, troneggiava sul nostro viso un sorriso estatico.
Verso sera, la felicità si mutava in un doloroso fastidio: le gambe prudevano, senza sosta. Anche se gli adulti cercavano di alleviare l’inconveniente con delle pomate, non bastava, le nostre gambe parevano essere state punte da migliaia di zanzare.
Fortunatamente il sonno dava tregua al prurito: al mattino quei duri momenti erano dimenticati.
Era fantastico vedere poi, giorno dopo giorno, quelle botti posizionate in fila sotto il portico, in attesa. Aspettavano le botti e aspettavamo noi, che quel meraviglioso nettare raggiungesse finalmente la consistenza ideale per essere estratto.
Era il contadino più anziano a decretare che si poteva finalmente bere: dopo avere annusato più volte e assaggiato il contenuto delle botti, incoraggiato dall’insistenza dei compagni che aspettavano con ansia il vino nuovo. Quel giorno si preparava una grande festa nella cascina.
Nessuno poteva mancare in quel giorno di festa, tutti erano presenti. Le donne pulivano con vigore le damigiane, dove gli uomini avrebbero versato il vino.
Solo due mesi erano passati dalla spremitura, in realtà era ancora troppo presto per travasare il vino, ma gli uomini da troppo tempo senza, erano ansiosi di assaggiare il frutto che le viti (con l’aiuto del buon Dio) avevano dato.
Dai volti e dai commenti, “buono”, oppure “ottimo”, si capiva all’istante se quell’anno la vendemmia era stata buona, e devo dire che mai li abbiamo visti lamentarsi.
Ad anni alterni sentivamo ripetersi le stesse frasi, che per noi bambini avevano un significato oscuro:
“Forse l’anno scorso il vino aveva un grado in più, era un po’ più secco.” Oppure: “Quest’anno è mosso, ideale anche per le signorine.”
Il significato di quelle parole forse non ci interessava neppure, ci sarebbe bastato assaggiare un po’ di vino spumeggiante, che con gesto automatico della mano i grandi si portavano alla bocca. La nostra richiesta veniva puntualmente respinta: eravamo ancora troppo piccoli per bere del vino. Questo rifiuto accresceva la nostra voglia, e accendeva il desiderio di sfidare gli adulti, imbrogliarli, bere di nascosto. Purtroppo l’assaggio clandestino non avvenne mai.
Passata la festa e trascorsi alcuni giorni, anche noi potevamo assaggiare il liquido che usciva da quelle stesse botti, precedentemente svuotate: ma quel vino era molto più chiaro, aveva un colore rosa pallido e profumava di ciliege. Il motivo di quel cambiamento, di quel diverso profumo e colore, noi bambini non lo conoscevamo…
L’abbiamo scoperto solo alcuni anni dopo. Quei furboni di contadini, dopo aver estratto tutto il vino, richiudevano il foro delle botti, muovevano i grappoli oramai striminziti al loro interno e le riempivano nuovamente, questa volta con acqua. Quando lo capimmo ci sembrò molto strano: solamente il Signore era riuscito a trasformare l’acqua in vino, eravamo certi che quei contadini non avrebbero potuto eguagliarlo.
L’acqua, mischiata agli acini rimasti nelle botti, dopo alcuni giorni assomigliava a un vino dal colore pallido e i contadini non chiamavano vino quel liquido, ma “Isenò”, nel dialetto del posto, che significa “acqua sporca” in italiano.
Vino leggero, dicevano, ideale da bere per i ragazzi e le donne.
Tutto questo non succede più da molto tempo, nella nostra cascina, dove un tempo si poteva camminare per chilometri e chilometri trovando solamente campi coltivati a grano, barbabietole e rape.
Adesso, invece, contro ogni aspettativa sono cresciute case su case, officine e grandi fabbriche. Per quanto possa spingere lontano lo sguardo, non vedo più la grande pianura uniforme, ma nient’altro che tetti e fabbriche che gettano nuvole di fumo.
Non ho mai avuto paura della solitudine dei campi, del silenzio delle notti, e neppure dei misteri delle ombre che la sera gli alberi stagliavano lungo i sentieri. Invece ho paura delle case, delle fabbriche che come mostri di cemento si alzano nel cielo.
Quanto erano belle quelle radiose sere d’estate, senza nuvole in cielo, senza un soffio nell’aria. Tanto più dolci e gaie erano per tutti: per i contadini seduti sulle soglie delle porte con l’espressione felice di chi aveva finito la giornata, per i lavoratori che tornavano dai campi e respiravano già il buon odore della minestra della sera. Persino per i cavalli, che si avvicinavano alla scuderia dove avrebbero riposato, davanti alle rastrelliere ben fornite.
Quanto più tristi e malinconiche sono adesso le sere, con tutto il fumo e l’odore acre che emanano le fabbriche.
Solo la nostra cascina è rimasta quasi uguale a quel tempo che non c’è più, in mezzo a tutto questo cemento.
Ed è lì, in quello scampolo di tempo perduto, che oggi anch’io, non più bambino, ho la mia bella cantina, dove numerose bottiglie di vino rosso e bianco, provenienti da tutta Italia e dalle terre di uno dei laghi più belli d’Italia, il Garda, fanno bella mostra di sé nelle scansie.
Ogni autunno, insieme ai vecchi amici di un tempo, ci riuniamo per festeggiare la vendemmia che non facciamo più, mangiando spiedo con polenta, accompagnato da un buon bicchiere di vino. Alla salute di tutti, dei presenti e di chi oramai ci ha lasciato, ma rimane vivo nel ricordo del nostro cuore.
***
Torna alla Silloge #RaccontItineranti per leggere altre opere ed altri autori.
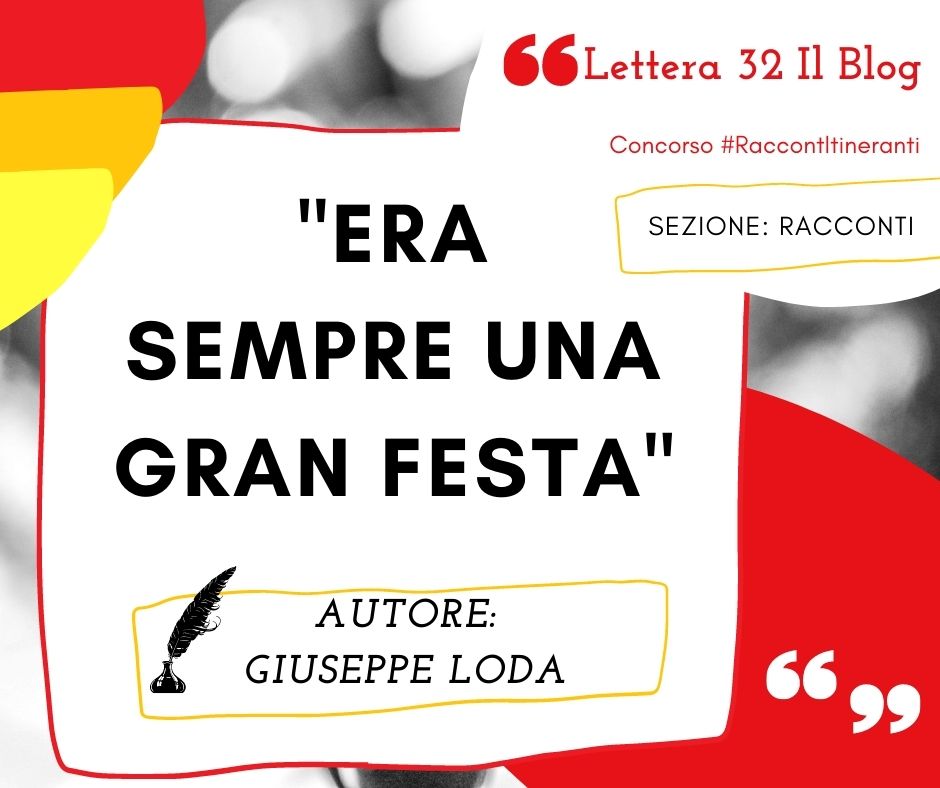




Bellissimo racconto, mi riporta ai tempi della mia giovinezza, quando da bambina ascoltavo sotto il portico i racconti della mia nonna.
Un tempo che ho avuto la fortuna di vivere,
ricordare e a tratti rimpiangere. Scorrevole, lento, dolce e ruvido ma elegante. Bello.